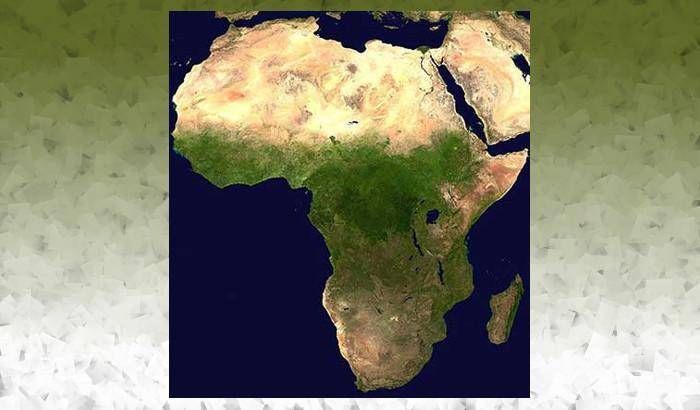di Saverio Lodato
È morto, ma difficilmente diventerà Immortale.
È morto, ma difficilmente diventerà Leggenda.
E c’è, di sicuro, che è morto.
Con Totò Riina, se ne va all’altro mondo un macellaio che incuteva terrore, un sadico sanguinario che godeva nel vedere agonizzare le sue vittime, un generale dissennato che portò Cosa Nostra in un vicolo cieco. Nessuno lo rimpiangerà. Nessuno sentirà il bisogno di emulare le sue gesta. Neanche altri grandi assassini come lui. Anche il Mondo del Crimine ha un suo vago senso del pudore.
Resteranno i suoi familiari, unici sulla faccia della terra, a dirsi orgogliosi di portare il suo nome. Riuscendo, magari, a strappare anche qualche comparsata TV.
Non c’è da stupirsi, anche uno come Totò Riina, fu padre e marito. E il sangue, almeno in questo, non mente.
Oggi si sprecheranno gli aggettivi, le esagerazioni iperboliche, si costruirà un monumento sinistro. Se ne canteranno le gesta, anche per enfatizzare le millanterie di chi rivendica il merito di averlo, a suo tempo, arrestato.
La storia è più semplice: è morto a 87 anni, in carcere, nel giorno del suo compleanno, un uomo rozzo che a stento parlava l’italiano, che si esprimeva prevalentemente a gesti e sguardi folgoranti, insensibile alla pietà, abile come un Borgia nell’arte del ricatto e del veleno, che si fece avanti, come un bulldozer, tra montagne di cadaveri. Che lui amava chiamare “tonni”, i quali, insomma – diceva lui – avevano fatto “la fine del tonno”.
E in quella montagna di cadaveri, finirono anche Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Emanuela Loi, Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Agostino Catalano…
Una gigantesca Spoon River di Sicilia che per trent’anni portò la sua firma: Totò Riina, corleonese, u’ curtu, capo dei capi perché era capace di uccidere meglio e più degli altri. Era questo il suo grande merito militare. Ma in fondo, il suo, resta il curriculum di una iena a piede libero.
E qui, a questo punto della storia nera, si addensano gli interrogativi.
È plausibile che una iena possa aver fatto tutto da sola?
È plausibile che una iena di tal fatta, sia riuscita a darsi alla macchia per quasi 30 anni? Che tanto durò, a conti fatti, la latitanza di Totò Riina, sino a quel fatidico 15 gennaio del 1993, quando per lui scattarono le manette nei pressi di via Bernini, a Palermo?
È plausibile che quel giorno, e neanche nelle settimane successive, a nessuno venne in mente di perquisire il suo covo, che ormai era individuato e a portata di mano?
E appare concepibile, con il senno di poi, che Cosa Nostra ebbe tutto il tempo di ripulire il covo di Riina, sradicando dal muro la cassaforte in cui erano custoditi i suoi dossier, i suoi libri mastri, gli elenchi degli uomini politici di allora compromessi con la mafia, in una parola: i suoi segreti?
E perché, ormai detenuto da tempo, lamentandosi di essere diventato un parafulmine, lasciava apertamente intendere che Bernardo Provenzano, l’altro boss corleonese che poi avrebbe preso il suo posto, era stato il Giuda che lo aveva consegnato ai carabinieri?
E in precedenza, come era stato possibile, mentre le forze di polizia, almeno sulla carta gli davano la caccia, che i suoi quattro figli nascessero, a loro nome, nelle cliniche di Palermo?
E perché mai, un uomo politico navigato e avveduto come Giulio Andreotti non si era sentito in imbarazzo incontrandolo in Sicilia, prima e dopo l’assassinio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana?
In altre parole: a chi fece comodo, per quasi mezzo secolo, la iena?
Riina è morto, neanche questo va dimenticato, senza vedere realizzato il suo ultimo grande sogno, quello che avrebbe dovuto essere il suo Capodopera criminale: l’uccisione del giudice Antonino Di Matteo che indaga sulla Trattativa Stato-Mafia; in quel processo di Palermo che vede alla sbarra, accanto a rispettabilissimi uomini politici, rappresentanti delle istituzioni, proprio lui: Totò Riina.
Poco tempo fa, aveva annunciato che si sarebbe sottoposto all’interrogatorio di Di Matteo. Poi, e ne scrivemmo qui, qualcuno lo fece ragionare, spiegandogli che faceva bene a restarsene zitto. E si rimangiò tutto. E, affinché non restassero dubbi, lui disse alla moglie, che era andata in carcere a trovarlo: “io non mi pentirò mai”.
De profundis, dunque, per un mafioso che, in mezzo secolo di vita criminale, diede del tu allo Stato e al Potere.
De profundis, per l’uomo che oggi è morto facendo la cosa che oltre ad uccidere, gli riusciva meglio: tenere la bocca cucita.
De profundis, per un uomo che non ebbe pietà neanche per Dio.
Cosa gli sopravvive?
La mafia.
Quella Mafia che oggi non muore con lui.
E che di lui non vorrà più sentir parlare.
La rubrica di Saverio Lodato
COME SOSTENERE PANDORATV.it: