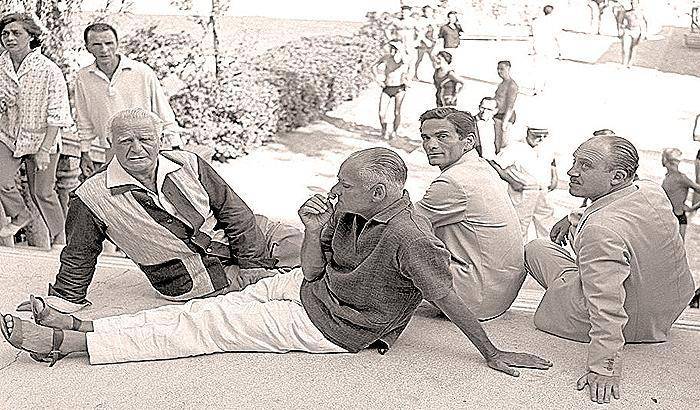di Franco La Cecla
In uno dei capitoli finali di Tristi Tropici Lévi-Strauss fa un’affermazione nei confronti dell’Islam che oggi sarebbe facilmente definibile come scorretta politicamente: “Sul piano estetico, il puritanesimo islamico, rinunciando ad abolire la sensualità si è contentato di ridurla alle sue forme minori, profumi, merletti, ricami e giardini. Sul piano morale ci si trova di fronte allo stesso equivoco di una tolleranza ostentata, a danno di un proselitismo il cui carattere compulsivo è chiaro. Effettivamente il contatto coi non-musulmani li mette in angoscia.
Il loro genere di vita provinciale si perpetua sotto la minaccia di altri generi di vita, più liberi e più facili del loro, che rischia di essere alterato con la sola contiguità. Piuttosto che parlare di tolleranza, sarebbe meglio dire che questa tolleranza, nella misura in cui esiste, è una continua vittoria su loro stessi. Preconizzandola, il Profeta li ha condannati a una situazione di crisi permanente, che risulta dalla contraddizione tra la portata universale della rivelazione e l’ammissione della pluralità delle fedi religiose” (Lévi-Strauss, 1955, pp. 344-345). A leggere solamente la prima parte di questa affermazione si potrebbe attribuirla a Salvini o a qualche pensatore (se ce n’è) della destra nostrana. Si è tentati di fare quell’associazione che per l’antropologo Jonathan Friedman, autore di Politicamente Corretto, il conformismo morale come regime (Meltemi 2018) ne è la caratteristica fondamentale. Questa definizione di associazione non deriva da quella di “metonimia” come vorrebbe Francesca Rigotti che ha recensito negativamente su questa stessa piattaforma il libro di Friedman, ma si riferisce ad un articolo di George Orwell “Politics and the English Language” (1956) che era un corollario alla Fattoria degli animali. Orwell, un autore che oggi alla pari di Friedman e di Lévi-Strauss sarebbe tacciabile di essere poco corretto politicamente (attaccava il socialismo reale e quindi per “associazione” era riconducibile alla destra e quindi fascista) ravvisava nell’associazione una molla fondamentale per decontestualizzare ogni affermazione e incasellarla in comodi cassetti.
Chi è critico della politica di Israele è antisemita, chi ha dubbi sulla questione emigrazione è razzista, chi non si schiera con me-too è un porco maschilista. Nella nuova ondata di puritanesimo che sta emergendo uno dei verbi vincenti è che “il politically correct” in fin dei conti è una morale e ci salva dalla corruzione e da tipi come Trump. Non ci si rende conto che il “politically correct” è un boomerang. Spacciando il suo semplicismo e radicalismo per morale fa fuori proprio ciò che vorrebbe salvare, trasforma in ideologia un rapporto onesto e fedele alla realtà, che accetti che essa è complicata e ambigua, ma che sicuramente non corrisponde a schemi come quelli della lavagna delle scuole medie (buoni/cattivi). Per certi versi il “politically correct” è la fine della società aperta e della società liberale, anche se per ora, come afferma Jonathan Friedman, è destinata a fare molti danni e a rappresentare un nuovo tipo di “regime”. Un modo per salvarsi da esso è scegliere di non “decontestualizzare”. Lévi-Strauss esprime le sue idee sull’Islam all’interno di un’opera e di un pensiero da cui non si può prescindere. Mi viene da pensare spesso in questi giorni che se oggi fossimo di fronte alla fatwa di Khomeini contro i Versetti Satanici potremmo essere tentati di essere “dalla parte degli offesi, vittime di uno scrittore occidentale con pregiudizi anti-islamici” (era la posizione di Cat Stevens, convertitosi all’Islam, che propugnava di essere pronto a tagliare la gola a Rushdie).
E allora cerchiamo di fare quello che Francesca Rigotti (che ha il merito di averci fatto capire che Politicamente Corretto di Friedman non è politicamente corretto – sembra di riprendere l’apologo del dito e della luna) non ha fatto. Contestualizziamo. Chi è Jonathan Friedman? È un antropologo di fama mondiale, allievo del grande Marshall Sahlins, che ha lavorato per anni sui sistemi politici delle tribù del Pakistan e poi in Polinesia e che ha insegnato per decenni all’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi e nella Università di San Diego in California.
A Parigi era all’interno di un laboratorio diretto da Michel Wieviorka, un sociologo che per molti anni è stato l’ispiratore delle politiche socialiste. Friedman è un antropologo post-marxista, anche se questa definizione gli viene strettissima, ma spiega il suo interesse estremo per i sistemi politici ed economici. Gli archeologi devono a lui il rinnovamento totale della riflessione sull’evoluzione sociale (la sequenza per cui si passa dalla caccia e raccolta, all’agricoltura e via dicendo). Sua moglie Kajsa Ekholm, un’africanista svedese, ha lavorato per anni in Congo sui casi dei bambini accusati di stregoneria. Nel libro di Friedman si tratta molto di lei, perché è stata accusata di razzismo in Svezia per avere cercato di attivare una discussione sui pro e i contro dell’immigrazione, a partire non da una sua opinione, ma dalla reazione di una parte della società svedese che si dimostrava preoccupata della poca riuscita delle politiche di assimilazione. Friedman a sua volta, per averne preso le difese, veniva accusato di xenofobia e tutt’ora, quando il suo libro è arrivato ai nostri quotidiani, i capiredattori hanno cercato online e vi hanno trovato la stessa accusa e in un primo tempo si sono rifiutati di farne una qualsivoglia recensione. Da un certo punto di vista la macchina del “politically correct” è inesorabile.
Non ammette ripensamenti e cancellazioni. Le basta lo “stigma”, figuriamoci se accetta il dibattito. Cosa dice il libro di Friedman (che è autore di opere imponenti sulla globalizzazione di cui io e Piero Zanini abbiamo curato una raccolta di saggi La quotidianità del sistema globale, 2005, Bruno Mondadori)? Racconta in più di trecento pagine molto complesse e difficili da rendere in un italiano fluente per i giornalisti la storia di sua moglie e quella della costruzione dell’accusa contro di lui in Svezia e poi si allarga per raccontare cosa sta diventando il “politically correct” oggi: molto semplicemente il rifiuto di avere dubbi su certi temi, il rifiuto del dibattito e soprattutto della ricerca, il “partito preso” come presupposto per ogni giudizio. Racconta la malattia della sinistra e dei progressisti, qualcosa che non mi sembra così difficile da verificare tutto intorno a noi e per cui non mi pare che occorra una particolare intelligenza. Ad esempio l’anno scorso è uscito nelle sale italiane il film A Ciambra di Jonas Carpignano, un docu-film sui Rom di Gioia Tauro, finanziato (per la pellicola) da Martin Scorsese. Un film duro, molto bello, frutto di cinque anni di ricerca sul campo e di convivenza di Carpignano con i Rom di Gioia Tauro, Rom che sopravvivono nel contesto criminale della ndrangheta di cui sono vittime.
Immediatamente su Facebook è sorta una campagna diffamatoria il cui tono era: “Non ce n’era veramente bisogno, questo film mostra i rom come se fossero dei ladri e dei delinquenti”. Alle mie rimostranze – alcune delle critiche venivano da persone che conosco bene – mi veniva ribadito che il cinema come l’arte deve essere “edificante”, deve mostrare come il mondo dovrebbe essere, non com’è. Inutile ribadire che questo tipo di atteggiamento distrugge l’onestà di fronte alla realtà e sostituisce ad essa la propaganda. È un po’ lo stesso atteggiamento di Rebecca Solnit quando sostiene che bisognerebbe proibire Lolita di Nabokov o di chi vuole coprire le vergogne di Egon Schiele. Ovviamente il libro di Jonathan Friedman è molto più complesso di così e non bisogna dimenticare che è il libro di un antropologo che parla di un mondo che da noi non è tanto familiare: l’antropologia come qualcosa che interagisce con il dibattito politico e culturale di un paese. D’altro canto Meltemi è una casa editrice che sta tentando, con tutti i limiti economici di una collana affidata all’energia di volontari, di svecchiare il panorama italiano delle Scienze Umane. Quindi i refusi, gli errori di stampa ravvisati dalla Rigotti sono imperdonabili ma anche rimediabili, e forse non vanno ascritti in una mentalità associativa alla “scorrettezza politica” del libro e dell’autore.
(17 febbraio 2018)
Link articolo: Politicamente corretto?