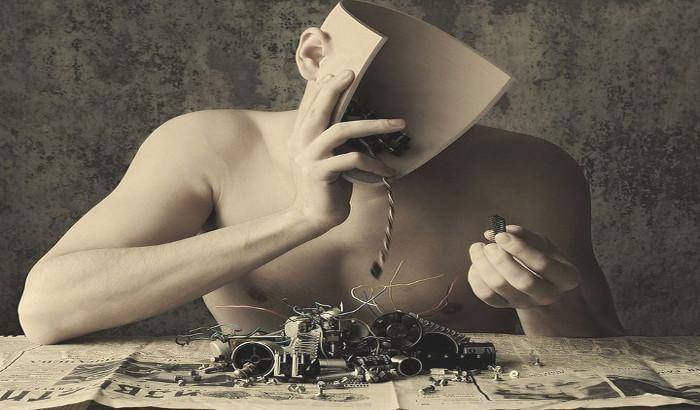ATF
di Lelio Demichelis.
L’articolo di Pierluigi Fagan, ripreso da Megachip è una sintesi perfetta dei problemi che affliggono questa nuova crisi di quella lunghissima modernità che ci accompagna dalla rivoluzione scientifica e soprattutto dalla prima rivoluzione industriale e dal tradimento ottocentesco della rivoluzione francese – quando nascono l’individuo moderno e il liberalismo ma anche, con Foucault, la società disciplinare/biopolitica e del controllo.
Ma allora, che fare? – davanti a questa crisi che nuovamente produce l’esplosione delle identità collettive, lo svuotamento delle identità individuali, la rinascita di autoritarismi nazionalismi e populismi, mentre illude di nuove soggettività/diritti individuali cancellando allo stesso tempo quei diritti sociali che ne sono la premessa e la sostanza?
Che fare? – davanti a un potere che de-sovranizza il demos espropriandolo della sua demo-crazia?
Servono risposte che siano davvero altre rispetto a quelle inventate fin qui dalla modernità per gestire il suo potere e le sue crisi (lo Stato, la sovranità, l’individuo, i totalitarismi, il fordismo, il consumismo, l’industria culturale, oggi la rete). Ed è sì assolutamente necessario, oltre che urgente provare a immaginare altrimenti, come sottolinea Paolo Bartolini nel suo contributo, cioè indicare delle discontinuità vere rispetto a questa infinita ma schizofrenica modernità. Stretta tra libertà e controllo, tra socialità e de-socializzazione, tra autonomia ed eteronomia, tra politica/polis e capitalismo/mercato, tra società e comunità.
Ma prima di cercare le possibili risposte proviamo ad aggiungere una ulteriore riflessione sulle cause che producono queste ricorrenti crisi della modernità. Evidenziando quella che per noi è la causa-prima e che si chiama tecnica/industria & capitalismo/mercato-competizione e quindi principio di prestazione e di accrescimento infinito del profitto capitalista e del biopotere degli apparati tecnici; che a sua volta si basa sul suddividere/parcellizzare per poi totalizzare.
Causa-prima che risiede nella razionalità calcolante/strumentale (ma in verità sempre più irrazionale) che appunto crea e poi domina la modernità e che incessantemente si replica ogni volta che qualcosa, grazie alla tecnica, può essere suddiviso, parcellizzato e calcolato e messo a valore/profitto/controllo (ieri lavoro e consumo; oggi vita, emozioni, competenze, socialità, identità, tempo, spazio; e ancora lavoro, oggi “uberizzato” e on demand), per poter essere poi ricomposto in unità/totalità dallo e nello stesso apparato. Apparato che dà poi esso stesso il senso del vivere e il contenuto/scopo di questo vivere agli individui che ha scomposto e diviso. Scopo che vuole la vita piegata alle sole esigenze della produzione, del consumo, dell’innovazione per l’innovazione; cioè alla volontà di potenza del sistema permessa da quella distruzione creatrice di schumpeteriana memoria che è l’imperativo categorico ma anche la dannazione nichilistica di ciò che chiamiamo tecno-capitalismo.
Fatta questa premessa, domandiamoci allora cosa significa o dovrebbe significare: immaginare altrimenti. Per noi significa (sì, anche) ri-tornare all’utopia come modello/metafora di un doveroso progettare/immaginare altrimenti. Zygmunt Bauman sosteneva – definendola utopia del giardiniere – come la modernità fosse nata dalla volontà umana di immaginare un giardino/società, di realizzarlo ma poi anche di curarlo e mantenerlo (manutenerlo), altrimenti le erbacce avrebbero rapidamente ri-preso il sopravvento.
Il bisogno/desiderio di utopia, ricordava sempre Bauman, nasce però solo quando vi è tra gli uomini il riconoscimento condiviso che le cose non stanno andando come dovrebbero; ma nasce, soprattutto quando questi stessi uomini, in società passano dalla consapevolezza critica alla convinzione/determinazione di avere la possibilità e soprattutto la capacità di cambiare le cose.
La prima condizione oggi esiste, ma si declina in rancore, nazionalismo e populismo funzionali alla ulteriore riproducibilità del sistema, manca invece del tutto la seconda condizione.
Il problema (sempre Bauman) è che oggi siamo passati dall’utopia del giardiniere (Illuminismo, Progresso) all’utopia del cacciatore: cioè di colui (la globalizzazione, la competizione, il neoliberalismo ma, aggiungiamo, anche la rete/tecnica), che sfrutta un territorio (fisico e/o sociale) fino all’esaurimento delle sue risorse/prede (noi stessi, l’ambiente, la società), lascia crescere le erbacce infestanti e poi, senza curarsi del dopo e degli altri passa a cacciare in altri territori. Di fatto, più che un’utopia, una totale distopia.
Ma in questa distopia moderna che incessantemente (ma funzionalmente alla crescente produttività richiesta a ciascuno) produce separazione, asocialità, sofferenza, esclusione, competizione, egoismo e nichilismo, il potere ha creato poi tutta una serie di maschere/terapie che offrono l’illusione di una socialità nuova (i social network), di non essere soli ma ben connessi/integrati in una comunità/community, di poter vivere in una democrazia anch’essa nuova (ancora grazie alla rete, democratica in sé e per noi).
Rispetto a ieri, l’immaginare altrimenti non nasce più dalla società (civile), dai corpi intermedi, dalle classi sociali conflittuali, dal pensiero critico, dai movimenti, dagli intellettuali, dall’arte (e meno che mai dai politici, fatte salve poche eccezioni, come Jeremy Corbyn) e anzi, la pedagogia neoliberale ci insegna fin da piccoli che il massimo della razionalità (e della nostra calcolabilità/mercificazione) è quella di adattarci all’innovazione e più in fretta lo facciamo, senza opposizioni, più accresciamo il nostro capitale umano di uomini nuovi tecno-capitalisti.
Di più: l’immaginare altrimenti (Think different, beyourself) è prodotto e offerto dallo stesso sistema che dall’altra parte omologa, uniforma, integra e incorpora ciascuno di noi in sé come nuovo corpo politico neo-hobbesiano, non più lo stato-leviatano di allora, ma tecnica e mercato che si fanno sovrano assoluto.
Avremmo un disperato bisogno di innovazione sociale, politica e culturale e invece siamo impegnati ogni giorno a immaginare/sognare/vivere solo innovazioni tecnologiche prodotte da altri per i propri profitti ma a cui associamo (ingenuamente) il nome di rivoluzione, convinti (sbagliando) che solo più tecnica (e non una tecnica migliore e soprattutto una tecnica democratizzata, noi riprendendoci il potere di rimetterla al suo giusto posto di mezzo al nostro servizio) ci permetterà di avere un mondo migliore, in attesa dell’algoritmo definitivo che tutto regolerà, anche noi stessi.
Se questo è vero, allora il primo dei compiti da assumerci per immaginare diversamente e organizzare diversamente il mondo è uscire da questo immaginario collettivo tecno-capitalista e dal suo spettacolare integrato – teologico e teleologico oltre che tecnologico – e smetterla ad esempio di considerare Amazon come qualcosa di assolutamente nuovo (è solo l’evoluzione del vecchio ‘Postal market’) o di pensare Facebook come qualcosa di davvero social riconoscendo che invece è una grande agenzia di pubblicità e una grande agenzia di spionaggio di massa (si legga l’articolo di John Lanchester uscito sulla London Review of Books e ripreso da Internazionale nr. 1222). Difficile, certo, è immaginare diversamente, perché la capacità trasformistica del tecno-capitalismo sa mettere a profitto per sé non solo il desiderio libertario di portare l’immaginazione al potere, come scritto sui muri del sessantotto parigino, ma sa produrre dentro di sé e per sé la nuova classe che lo rafforzerà invece di abbatterlo, ovvero la nuova classe degli imprenditori di se stessi.
Scriveva l’economista Claudio Napoleoni che compito prioritario della sinistra doveva essere quello di mantenere (e semmai di accrescere) la massima distanza/differenza possibile tra capitalismo e società. Il filosofo Gunther Anders scriveva invece di forme tecniche che diventano forme sociali. Quella distanza/differenza oggi si è (quasi) azzerata, la società ha assunto una forma capitalistica e tecnica – anche o soprattutto per colpa (una colpa culturale, politica, sociale) delle sinistre.
Quella distanza deve essere ripristinata al più presto, perché se è vero che il capitalismo è una religione (Walter Benjamin), o (come abbiamo scritto) che lo è il tecno-capitalismo, occorre laicizzare il sistema, separare lo stato dalla chiesa tecno-capitalista e uscire dal dogma neoliberale. Certo, anche questo non è facile, perché oggi tecnica e capitalismo hanno conquistato (in senso gramsciano) l’egemonia e il dominio. Ma questo rende tutto più urgente. E se il tecno-capitalismo ci ha fatto regredire dal contratto sociale allo stato di natura dell’homo oeconomicus però istituzionalizzandolo/legalizzandolo/promuovendolo – perché questo serve alla distruzione creatrice – allora occorre recuperare anche quella cosa che si chiamava contratto sociale ma riscrivendolo nella forma di contratto sociale e naturale, per l’ambiente e il futuro.
Queste ci sembrano, allora, le premesse necessarie – smantellare la macchina dell’immaginario collettivo e riscrivere il contratto sociale – per uscire dal tecno-capitalismo senza cadere/scivolare nella nostalgia dello stato-nazione, del sovranismo, del populismo. Perché la globalizzazione non è morta e non morirà; perché la stessa globalizzazione (i poteri che l’hanno generata) è divenuta consapevole della crisi che ha prodotto e corre ai ripari offrendo al pubblico dello spettacolare politico integrato della globalizzazione una illusione di ritorno alla sovranità popolare, così come lo stesso apparato che de-socializza offre i social come ammorbidente esistenziale; perché populista non è solo Grillo, ma anche Trump e Macron, invenzioni politiche del sistema per la propria riproducibilità.
Occorre dunque una democratizzazione dal basso di tecnica e capitalismo, cioè dei poteri (a-democratici e anti-democratici per forma e vocazione) oggi al potere nel mondo; che vanno controllati dal demos e bilanciati, ma soprattutto spezzati e distribuiti tra le persone (Roberto Mancini).
Invece di sognare un passato inesistente fatto di stati nazionali comunque tecno-capitalisti (la retrotopia dell’ultimo Bauman, in realtà non è che l’ultima fase della distopia tecno-capitalistica), occorre ritrovare la volontà/capacità di immaginare ed essere capaci di soggettivazione/individuazione.
La battaglia, prima che politica, è culturale e riguarda il nostro rapporto con tecnica e capitalismo – e con quella rete che è oggi la Fabbrica-mezzo di connessione/produzione in cui tutti siamo messi al lavoro, dove quindi va portato il conflitto, distanziando sempre più la società dal biopotere esercitato sulle nostre vite da tecnica e capitalismo.
COME SOSTENERE PANDORATV.it: