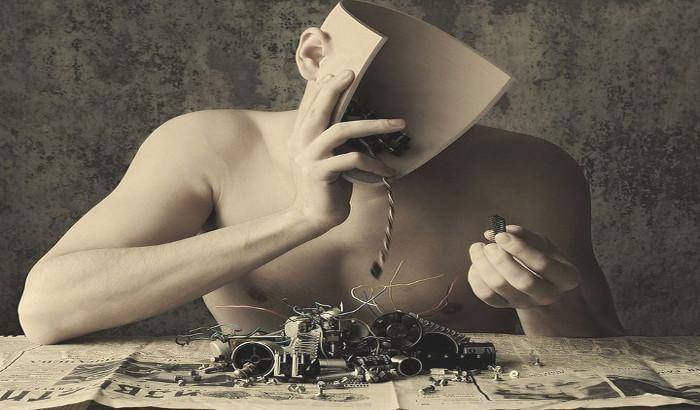di Matteo Vegetti.
Un recente articolo pubblicato da Pierluigi Fagan su Megachip (Lo spazio del politico nel mondo multipolare. Nuovi Stati, secessioni, sovranità) solleva un insieme di questioni rilevanti, addirittura centrali per comprendere il nostro tempo, e pertanto non sorprende che abbia suscitato le altrettanto interessanti riflessioni di Fabio Marcelli, Paolo Bartolini e Lelio Demichelis.
Quelle che Fagan identifica come le quattro forze produttive di una trasformazione geopolitica planetaria si potrebbero a mio avviso anche intendere come altrettante sfide, nel senso che Collingwood ha attribuito all’espressione nella sua Question Answer-Logic. Una sfida (Challenge) di questo genere sorge infatti nel momento stesso in cui l’azione congiunta di forze sociali di varia natura determina un mutamento storico di tale portata da esigere una risposta politica innovativa in grado di contenerne gli effetti.
La prima minaccia che grava sull’assetto geopolitico attuale è di natura demografica. Su questo Fagan ha certamente ragione. Il vertiginoso aumento della pressione demografica nei cosiddetti paesi in via di sviluppo (mi riferisco in particolare a quelli africani, dove per altro lo sviluppo economico è progressivamente fiaccato dalle guerre civili e forse anche dal mutamento climatico), condurrà certamente ai problemi che l’autore ha posto in luce (e ad altri ancora, come l’inurbamento di enormi masse di diseredati che andranno ad accrescere gli attuali slum o che, per altro verso, proprio perché sradicate e ingovernabili, accentueranno le dinamiche migratorie interne ed esterne al continente).
Fagan menziona poi altre forze destinate a mandare in crisi l’assetto geopolitico attuale: l’ascesa di nuove potenze globali (Cina e Russia su tutte), l’implosione dell’ordine statuale generato dal colonialismo in Africa, il tentativo degli Stati Uniti di legittimare in base al principio wilsoniano dell’autodeterminazione dei popoli i movimenti secessionisti basati su fattori etnici o religiosi, la crisi economica che tende a riaccendere l’antagonismo all’interno di Stati disomogenei dal punto di vista economico, ma anche etnico o identitario (si pensi al recente caso catalano).
Tutto questo secondo Fagan dovrebbe comportare – in parte già comporta – due fenomeni apparentemente contraddittori: da un lato la moltiplicazione, direi l’iperfetazione, della forma-Stato, dall’altro la genesi di una «rete complessa di inter-nazionalizzazioni» che non rispondono più alla logica delle tradizionali istituzioni economiche internazionali. Entrambi i fenomeni si andranno poi a verificare nella cornice di un mondo, poliarchico, irriducibile al controllo unilateralmente esercitato dagli Stati Uniti.
Occorre però notare che la moltiplicazione della statualità non è affatto in contraddizione con la tesi che ne sostiene la crisi. La salute dell’istituzione statale centralizzata non si misura infatti dal numero degli Stati esistenti, ma dall’efficacia della loro sovranità nel governare i fenomeni che ne attraversano i territori. Da questo punto di vista, come Fagan sa bene, e nonostante consideri lo Stato «l’unico attore in grado di intenzionalità ragionata e strategica» rispetto ai problemi da gestire (non so se intenda questo “di fatto” o “per principio”), la statualità vive un periodo di crisi tanto profonda da richiedere l’invenzione di forme politiche metastatuali (o forse sovrastatuali, non comunque post-statuali, dato che – secondo la tesi di Fagan – dovrebbero essere ancora una volta Stati sovrani).
La globalizzazione è infatti un processo che, soprattutto sotto il profilo economico (ovvio pensare al capitale finanziario), svuota la sovranità degli Stati, sottraendo loro la capacità di governare le sfide globali. Di qui appunto la necessità che il politico riacquisti il suo primato attraverso una diversa dimensione spaziale, più ampia e al tempo stesso in grado di riassorbire al suo interno le diverse spinte autonomiste.
Questo non è però già più un discorso generale. Non riguarda per esempio gli Stati Uniti, la Cina o la Russia, e neppure l’Africa o il Medio Oriente.
Fagan, a qualche livello, sta qui assegnando un compito all’Europa, quello di diventare – in che modo, poi lo vedremo – un vero soggetto politico, non una semplice Unione monetaria.
In tutto questo c’è evidentemente qualcosa di condivisibile, sia nell’istanza volta a contenere i secessionismi e i particolarismi, sia in quella volta a rifondare politicamente l’Europa.
Per altro verso però non vedo come la spinta verso l’autonomia di etnie, regioni, stati sia conciliabile con l’auspicata formazione di un super-Stato europeo (per quanto federale possa essere). Le forze autonomiste e separatiste che attraversano il vecchio continente rigettano in nome della loro sovranità anche questa Europa politicamente debole; perché dovrebbero dunque ambire ad appartenere a un’Europa più forte? E quale processo politico dovrebbe condurre gli Stati membri a rinunciare a ulteriori margini di sovranità per promuovere questo nuovo tipo di Stato? La Brexit è un chiaro indice di quanto sia difficile immaginare questo processo. Un’Europa senza Inghilterra è a mio avviso un’idea geopolitica insostenibile. Ma al di là di questo una vena antieuropeista e sovranista attraversa tutti gli Stati europei, e soprattutto quelli ricchi, poiché pare non abbiano interesse a redistribuire la propria ricchezza più di quanto non facciano già adesso.
Appellarsi in tal senso a generici processi democratici mi pare rischioso: anche la Brexit o il nuovo corso di Trump sono stati democraticamente legittimati. Non c’è in effetti alcun rapporto tra i processi democratici di legittimazione della sovranità e i valori che dovrebbero derivarne. Legare i processi democratici, che sono preziosi meccanismi di legittimazione, al piano dei valori, vorrebbe dire che la democrazia delibera sempre per il meglio, il che mi sembra una pretesa francamente eccessiva, anche perché cosa sia “il meglio” è una questione politico-morale: l’espressione di giudizi e preferenze liberamente argomentabili, non certo un valore in sé e per sé.
Per intenderci, un «movimento fondativo radicalmente democratico» (sono belle parole di Fagan), potrebbe ugualmente promuovere l’integrazione dello spazio europeo come la sua disintegrazione (e tutto sommato la seconda ipotesi mi sembra più verosimile della prima: dico verosimile, non giusta o desiderabile).
Fagan allude però nel suo articolo a un’ipotesi ulteriore. Quella di un’Europa tripartita, ovvero comprendente tre formazioni Statali sovranazionali: una che raduna gli stati mediterranei, una i paesi europei del Nord e un’altra i paesi Slavi.
L’idea più affascinante, quella che investe gli Stati mediterranei del compito di federarsi, risale al filosofo Alexandre Kojève, che la formulò nel 1945 con la clausola scontata che la Francia, come nazione più ricca e influente dell’area, avrebbe assunto la guida politica della federazione, da lui battezzata “Impero latino”. Non a caso l’idea è stata poi raccolta da Sarkozy sotto le ambiziose vesti di un'”Unione per il Mediterraneo” (ovviamente prima dell’attacco sferrato dalla Francia alla Libia).
Ma una piccola Europa di Stati a guida francese, marginale rispetto alle grandi rotte oceaniche della globalizzazione, ed invece sola nel compito di fronteggiare la minaccia di enormi flussi migratori provenienti dall’Africa (quelli di cui si diceva all’inizio, in previsione di una prossima esplosione demografica) sarebbe davvero una prospettiva allettante? Personalmente ho molti dubbi: soprattutto non mi pare una risposta adeguata alle sfide epocali di cui parla giustamente Fagan.
Un ulteriore dilemma relativo allo spazio geo-politico mediterraneo riguarda ovviamente i suoi limiti, o meglio il criterio per definirli. A meno di non ridurlo al sud Europa cattolico (come Kojève avrebbe desiderato, senza però crederci troppo, ed arrivando fino a proporre un’intesa tra latinità e Islam) il Mediterraneo è politeista, etnologicamente e culturalmente diversificato come nessun’altra regione del mondo. Paesi come la Turchia, la Macedonia, o l’Albania, tanto per intenderci, appartengono o non appartengono all’area geo-storica mediterranea? E Israele?
È evidente, mi pare, che geografia e storia non vanno del tutto d’accordo, e che se anche fossero sovrapponibili, non farebbero ancora un concetto geo-politico.
Da Reclus a Haushofer, la geografia ha sempre tentato di trovare criteri plausibili per definire spazi politici (l’anarchico Reclus fu in effetti il primo a definire un’area geografico-storico mediterranea che avrebbe dovuto fornire la base per uno spazio politico antagonista rispetto a quello su cui la Germania esercitava la propria egemonia) ma la politica europea si rifiuta alle naturalizzazioni, perché segue altre logiche. Logiche artificiali, come quelle che fanno dello Stato, in quanto prodotto dello spirito illuministico europeo, una forza neutralizzante le differenze etniche e religiose. Il principio della sovranità territoriale centralizzata, se risponde a logiche statali, non risponde perciò a criteri geo-storici (criteri che non sono per altro mai oggettivabili, e che anzi sono loro stessi sempre una questione politica, un pretesto politico, di natura di volta in volta confessionale, etnico, linguistico, culturale ecc.).
Vengo ora alla questione più complessa, quella del rapporto tra economia e Stato. Fagan sostiene nell’articolo una tesi molto diffusa e in parte condivisibile, quella secondo la quale, a discapito della sovranità e dunque dei processi di partecipazione democratica, l’economico ha soverchiato il politico. In sostanza, nel mondo globalizzato, «il politico è stato confinato al ruolo di fornitore e protettore di condizioni di possibilità per l’economico».
Può darsi che questo sia vero, e tanti grandi autori potrebbero essere convocati a conferma della la tesi in questione. Ma io mi chiedo piuttosto quando, lungo il corso della storia del capitalismo, che coincide con la nascita dello Stato e con lo sviluppo di uno mercato mondiale, ovvero con la modernità stessa, non sia stato così. Forse la recente crisi degli enti intermedi (partiti, sindacati ecc.) ha accentuato il fenomeno, intaccando le dinamiche di partecipazione pubblica alla politica e soprattutto la redistribuzione politica della ricchezza (il welfare); ma mi pare comunque difficile contrapporre l’economia di mercato allo Stato (all’esercizio della sovranità nella guerra, nel governo della produzione, nella fiscalità, nelle logiche di inclusione) facendone forze antagoniste. Non occorre richiamarsi a Marx per sapere che il legame tra l’economia capitalistica e lo Stato è sempre stato molto forte e di reciproco vantaggio; che l’economico ha sempre cercato di strumentalizzare lo Stato nel proprio interesse e che lo Stato si è fatto garante degli interessi nazionali e del capitalismo di bandiera come potenza diplomatica, militare, legale, poliziesca ecc.
La globalizzazione ha mutato qualcosa in tutto questo? Perché ci troviamo a difendere lo Stato (sorprendentemente diventato un potere buono e necessario per conservatori e progressisti) contro il capitalismo globalizzato, quasi che questo fosse un avversario esterno allo Stato?
Mentre si invoca il ripristino del primato del politico sull’economico (un primato che non c’è mai stato, neppure al tempo dei totalitarismi, quando il principio di sovranità non era certo in crisi, e neppure mancava il consenso) non si sta forse rimpiangendo, in realtà, una forma di Stato precedente, ovvero quella alleanza tra capitalismo e Stato, tipicamente moderna, che tutto sommato portava in modo diretto o indiretto vantaggi all’economia nazionale?
In un saggio recente (L’invenzione del globo, Einaudi 2017) ho proposto una possibile chiave per distinguere tra due fasi interne alla storia del divenire mondiale dell’economia, quella della mondializzazione (che arriva fino al crollo dell’impero sovietico) e quella della globalizzazione in senso proprio, che arriva fino a noi.
In breve, intendo con la prima espressione un sistema-mondo basato sulle economie nazionali; un assetto geo-economico nel quale gli interessi strategici della grande industria collimano sostanzialmente con quelli dello Stato, con la sua politica interna ed estera. Protezionismo mercantile, svalutazioni, dazi, guerre economiche e militari: lo Stato rappresenta sullo scacchiere planetario i grandi interessi economici nazionali, i quali a loro volta si incaricano di compiti “governamentali”, come direbbe Foucault (basta in proposito pensare al ruolo sociale svolto dalla grande industria automobilistica in Italia, in Francia, in Germania o in America).
Chiamo invece globalizzazione la fase in cui l’economia finanziaria e le imprese globali, col supporto indispensabile di nuove tecnologie di rete, hanno iniziato a rendersi largamente indipendenti dai contesti politici nazionali (di qui l’impressione che la globalizzazione sia il fuori dello Stato), pur operando dentro i territori statali (dove se no?), cioè nei grandi centri urbani dell’economia globalizzata.
La sensazione che l’economico sia predominante rispetto al politico è allora a mio avviso figlia della perdita di controllo degli Stati nazionali sui settori globalizzati dell’economia (che non sono tutti, ovviamente, ma che essendo fortemente interconnessi ripercuotono i loro effetti – positivi o negativi – seguendo le vie di una geografia economica che non ha nulla a che vedere quella politica o geo-storica).
Mondializzazione e globalizzazione si sovrappongono e non si escludono reciprocamente (anche se possono entrare in conflitto sul piano sociale). Ma mentre il compito dello Stato rispetto all’economia nel contesto mondializzato è quello di favorirla e di dirigerla, nel contesto globalizzato è quello di attrarla, di creare le condizioni a lei più favorevoli affinché non traslochi altrove, a prescindere dalla sua origine.
Così il capitalismo globalizzato mette in concorrenza tra loro gli Stati, o più precisamente, i territori, giacché questi possono godere di potenzialità, risorse, privilegi peculiari e relativamente autonomi dal contesto nazionale in cui si trovano.
Le tesi che ho cercato di esporre non vanno, per quanto mi riguarda, contro l’idea di un’Europa più unita e più forte. Anzi, la sostengono. Nel contesto di un mondo poliarchico, come in effetti si sta disegnando, un’Europa politicamente integrata potrebbe più efficacemente difendere nella competizione dei mercati non solo, come è ovvio, gli interessi della Comunità, ma anche un insieme di valori tipicamente europei (diritti civili, welfare, laicità, libertà di espressione, tolleranza); valori che non si sono globalizzati alla stessa velocità dei mercati, e che anzi appaiono sempre più unici e preziosi. Piuttosto che sulla base di comunità o fisionomie geostoriche, è su questo terreno che a mio avviso andrebbe ripensata l’idea di Europa.
Matteo Vegetti, filosofo, insegna presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio (Università della Svizzera Italiana). Tra le sue pubblicazioni: L’invenzione del globo (Torino, 2017), La fine della storia (Milano 2000), Hegel e i confini dell’Occidente (Napoli 2005), Lessico sociofilosofico della città (curatela, con P. Perulli, Varese 2006), Filosofie della metropoli (curatela, Roma 2009).
COME SOSTENERE PANDORATV.it: