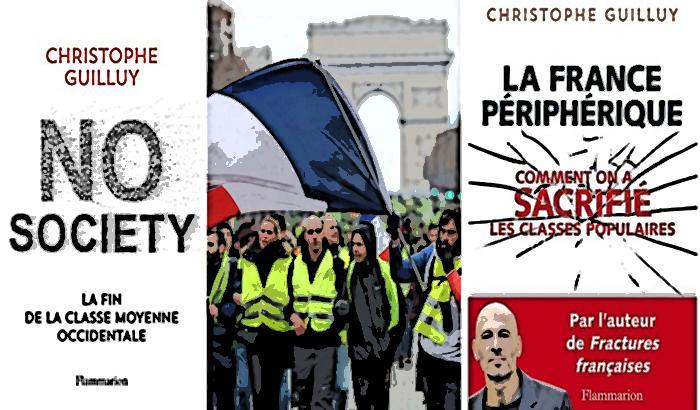di Carlo Formenti
Sull’ultimo numero del 2017, nel suo Almanacco di Filosofia, “MicroMega” ospita la dura polemica che ha opposto, da un lato, lo storico Vojin Saša Vukadinovič e Alice Schwarzer (direttrice di EMMA, rivista storica del femminismo tedesco), dall’altro, la filosofa statunitense Judith Butler e la sociologa tedesca Sabine Hark. Prendendo spunto da letture dissonanti del noto episodio della notte del 31 dicembre 2015, allorché una folla di immigrati musulmani invase il centro di Colonia esercitando molestie sessuali nei confronti delle cittadine tedesche che festeggiavano il capodanno, i due fronti si sono scambiati accuse di razzismo (Butler – Hark contro Vukadinovič – Schwarzer) e di un relativismo culturale giustificatorio, se non complice, nei confronti delle pulsioni maschiliste dell’islamismo (Vukadinovič – Schwarzer contro Butler – Hark). Al netto della virulenza verbale (con insulti reciproci degni di una rissa fra stalinisti e trotskisti), il confronto sollecita una riflessione in merito a ciò che mi pare caratterizzi buona parte del dibattito teorico, tanto nel campo femminista “ortodosso” quanto in quello dei gender studies, vale a dire una sorta di oscillazione fra cattivo universalismo e cattivo relativismo. Cercherò di argomentare quanto appena affermato commentando, oltre che i testi sopra citati, la beffa architettata da Peter Boghossian e James Lindasy ai danni delle derive postmoderne negli studi di genere[ii], alcuni passaggi di un recente libro di Judith Butler[iii], un’intervista rilasciata dalla filosofa Luisa Muraro nel 2016[iv], infine un articolo di Nancy Fraser pubblicato su “Micromega” online[v].
Parto dall’esilarante “fake paper” del duo Boghossian – Lindsay. Si tratta di un testo intenzionalmente delirante che i due hanno sottoposto al vaglio di una rivista “scientifica” di studi di genere, ottenendone la pubblicazione in barba alla bibliografia in larga parte falsa, se non inventata di sana pianta, e all’incredibile florilegio di affermazioni insensate (si va dalla tesi che la postura dei maschi che siedono a gambe larghe è il riflesso di un atteggiamento di “stupro dello spazio vuoto circostante”, alla denuncia della responsabilità del pene come “propulsore concettuale del cambiamento climatico”, in quanto quest’ultimo è l’esito inevitabile “di uno stupro della natura da parte di una mentalità maschile predominante”). Gli autori spiegano di aver tratto ispirazione da un’operazione effettuata anni fa dal fisico Alan Sokal, il quale si proponeva di denunciare l’uso improprio di metafore mutuate dalle scienze naturali da parte degli studiosi postmodernisti di scienze sociali (il bersaglio era il gergo dei cultural studies con particolare riferimento agli studi postcoloniali). Boghossian e Lindsay sostengono che, a far accettare come ovvie verità le insensatezze inserite nel loro testo (alcune delle quali formulate ricorrendo al Generatore Postmoderno, un algoritmo creato da Alan Sokal), è stato il tono “moraleggiante” (leggi: la denuncia della natura intrinsecamente malvagia della mascolinità), mentre aggiungono di non nutrire illusioni in merito all’effetto demistificante della provocazione, in quanto il campo dei gender studies è affetto da dissonanza cognitiva, si fonda cioè su certezze aprioristiche che sfidano ogni smentita empirica. Una di tali certezze coincide con la convinzione secondo cui il pene anatomico avrebbe poco o nulla a che fare, non solo con il genere, ma persino con il sesso.
Contro tale dogma si rivolgono a loro volta Vukadinovič e Schwarzer, mettendo in luce come i teorici del gender facciano derivare dalla consapevolezza della storicità dei ruoli di genere, e dall’assunto che dietro di essi non si darebbero alcuna natura né alcuna realtà, la libera e arbitraria modificabilità degli stessi (costoro, scrive Schwarzer in proposito, “scambiano i propri giochi mentali per la realtà, suggeriscono che ogni essere umano può essere, qui e ora, esattamente quello che sente di essere”). Fin qui siamo nell’ambito del dibattito filosofico. Le cose si surriscaldano e assumono valenza politica laddove Vukadinovič sottolinea come dalle rivendicazioni del diritto a essere ciò che si sente di essere, venga fatta discendere la richiesta di “ripulire” testi accademici e letterari, linguaggio quotidiano, fenomeni sociali e problemi politici di tutto ciò che può essere ritenuto offensivo nei confronti di questo o quel gruppo di “emarginati”, fino all’invito a strappare le pagine dei testi incriminati (quando il politicamente corretto tocca vette che evocano sinistri ricordi dei roghi nazisti di libri). E il calore sale ulteriormente laddove alla Butler viene rimproverato di non avere preso una posizione chiara e netta contro “l’orda di Colonia”, un’ambiguità che la filosofa statunitense giustifica con la necessità di tenere conto dell’esistenza di una differenza culturale che – nella misura in cui venisse ignorata – rischierebbe di far slittare l’indignazione femminista verso l’indignazione razzista.
Per cercare di precisare meglio il punto di vista di Judith Butler – a mio avviso più complesso rispetto a quello esposto dai suoi critici nel contesto appena illustrato, ma soprattutto non omologabile a quello degli esponenti più deliranti della gender theory– preferisco fare riferimento, invece che alla breve replica apparsa su “Micromega” (resa meno efficace dal risentimento nei confronti dei detrattori, che vengono persino accusati di “trumpismo”), a uno dei suoi libri più recenti[vi]. Le critiche che Butler rivolge all’universalismo del femminismo mainstream (facendo riferimento, per esempio, all’appoggio nei confronti delle leggi francesi che puniscono le donne che indossano il velo) prendono le mosse dalla convinzione che le donne dovrebbero riconoscere: 1) che esse non sono l’unico segmento di popolazione esposto a condizioni di precarietà e di privazione dei diritti; 2) che la popolazione sussumibile sotto la denominazione minoranze di genere e sessuali (quindi non solo le donne ma la comunità LGBTQ) è differenziata al proprio interno in termini di classe, razza, religione, appartenenze comunitarie linguistiche e culturali. Da questa duplice presa d’atto, viene fatta derivare un’importante conseguenza politica: il movimento femminista dovrebbe diffidare delle forme di riconoscimento pubblico (riconoscimenti, aggiungo io, che oggi gli piovono generosamente addosso da partiti e governi di centro, destra e sinistra, media, canzoni, film, programmi televisivi, aule parlamentari e di tribunale, ecc.) soprattutto se e quando tali riconoscimenti servono a deviare l’attenzione dal massiccio disconoscimento dei diritti di altri soggetti. In conclusione: se Butler parla della necessità, in casi come quello della notte di Colonia, di trovare il modo di portare avanti un discorso antisessista che sia al tempo stesso antirazzista, non lo fa per negare la gravità dell’episodio, bensì perché si ritiene impegnata a indagare le vie attraverso le quali “a precarietà potrebbe operare come luogo di alleanza fra gruppi di persone che, al di là di essa, hanno poco in comune, o tra i quali c’è talvolta persino diffidenza o antagonismo”.
Non discuterò qui le strategie politiche che, secondo Butler, dovrebbero consentire di costruire tale alleanza (personalmente non le condivido, e in ogni caso non sono qui il tema principale). Sta di fatto che, almeno a mio parere, la sua critica a un certo cattivo universalismo coglie nel segno. Nel mio ultimo libro[vii], riferendomi agli attentati terroristici effettuati da immigrati di terza e quarta generazione in Francia, ho a mia volta sostenuto la necessità di non appiattirsi sul coro delle esecrazioni contro il fanatismo islamico in nome dei “valori universali” incarnati dalle democrazie occidentali[viii], rimuovendo, fra gli altri fatti: 1) che molti di quei ragazzi non solo non erano stati assidui praticanti religiosi fino a poco prima di commettere attentati, ma avevano condotto vite simili a quelle dei coetanei occidentali; 2) che in molti casi avevano vissuto esperienze radicali di esclusione e marginalità, alle quali, non solo le élite dominanti, ma nemmeno le sinistre tradizionali avevano saputo offrire risposte; 3) che la scelta di luoghi di consumo e divertimento come bersagli rispecchiava la frustrazione per la loro condizione di esclusi per cui poteva essere letta anche come espressione di un odio di classe (rafforzato dal conflitto razziale) “pervertito” in fanatismo religioso. Ciò non ha nulla a che fare con una “giustificazione” del terrorismo, così come penso che l’invito della Butler di andare al di là dell’esecrazione contro “l’orda di Colonia” non abbia nulla a che fare con una giustificazione della violenza maschilista. Il problema di un certo cattivo universalismo femminista deriva a mio parere dall’eredità che il femminismo degli anni Sessanta – Settanta ha mutuato dalla visione delle sinistre neomarxiste, mettendo in atto una sorta di slittamento dalla classe operaia al genere femminile come incarnazioni dell’interesse generale dell’umanità. Questa visione – variamente trasfigurata – si è perpetuata fino ai giorni nostri in barba alla progressiva disarticolazione delle strutture e delle identità sociali, fino all’attuale frammentazione di soggettività economiche, politiche, ideologiche, culturali, religiose, etniche, sessuali, ecc. Ma la sua riproposizione in condizioni storiche mutate finisce di fatto per sposare i valori dell’universalismo borghese occidentale, con la conseguenza di tracciare confini amico/nemico semplificati, che neutralizzano il groviglio di antagonismi sempre più complessi e intrecciati cui ci troviamo di fronte.
Tutto questo significa che la ragione sta tutta dalla parte di Judith Butler, mentre gli argomenti dei suoi critici sono inconsistenti? Assolutamente no, perché – ancorché più sofisticata di altri e altre esponenti della teoria gender – la visione della Butler incarna l’altro corno della contraddizione che richiamavo poco sopra, vale a dire quello del “cattivo relativismo”. Criticando l’universalismo femminista, la Butler rivendica infatti la propria opposizione a “un pensiero che astrae dalla persona nella sua individualità e dalle circostanze in cui si colloca”. Ma tale affermazione conferma che ci troviamo di fronte al tentativo “estremo e individualistico”, per usare le parole di Luisa Muraro[ix], di assumere nell’identità personale qualunque identità. L’esaltazione delle “singolarità” – che accomuna i gender studies alle correnti mainstream delle teorie postcoloniali, delle filosofie poststrutturaliste e del postoperaismo – è infatti un tratto caratterizzante di quel pensiero “americanizzato” che tende a neutralizzare le differenze <
Chiudo questa prima parte del mio intervento, ricordando che l’intervista da cui ho tratto le citazioni da Luisa Muraro risale al periodo in cui la filosofa aveva pubblicamente denunciato il business della maternità surrogata come un attacco diretto alla relazione materna, beccandosi (a conferma della furia censoria sopra denunciata da Vukadinovič) l’accusa di “seminare odio contro gli omosessuali”. Sempre in quella occasione, aveva affermato, a proposito dell’illusione di poter scegliere arbitrariamente di essere quello che si vuole/crede di essere: “Cos’è la differenza sessuale? È la vita stessa. Ben prima che apparissero gli esseri umani la vita si è biforcata in maschio e femmina. Vogliamo cancellare questa cosa o la vogliamo tradurre in cultura? Io dico: non buttiamoci sulla differenza sessuale secondo le interpretazioni che di essa abbiamo ereditato. Poniamoci davanti, in tutta tranquillità e libertà, il problema che noi siamo esseri radicati nella vita naturale e la sessualità è eredità che la natura ci affida (sottolineatura mia). Non rimuoviamo questa evidenza e andiamo avanti, al di là di ogni stereotipo, a interpretarla culturalmente”[xi].
Intendo ora spostare il discorso su un piano meno filosofico e più politico. Il momento di rilancio che il movimento femminista sta vivendo grazie alle mobilitazioni promosse dalle militanti di “Non una di meno” sembra avere rimesso al centro dell’attenzione i temi del lavoro, riattivando la vocazione anticapitalista del femminismo anni Sessanta/Settanta. Una vocazione che era andata esaurendosi, sia perché la lotta per l’acquisizione di diritti individuali e civili nell’ambito del sistema esistente aveva preso il posto della lotta al sistema in quanto tale, sia perché si assumeva che lottare contro il patriarcato implicasse automaticamente lottare contro il capitalismo (tornerò più avanti sull’insostenibilità di questa identificazione fra sistema patriarcale e sistema capitalistico). Il ritorno di temi e obiettivi chiaramente anticapitalisti al centro della cultura e della pratica femministe è un evento di grande peso politico, ma finora tale svolta non è coincisa con l’abbandono di temi, obiettivi e valori tipici del femminismo identitario, emancipazionista-paritario nonché della cultura “genderista” di cui ho cercato di evidenziare limiti e contraddizioni. La domanda è: esistono, all’interno del campo femminista, punti di vista teorici in grado di superare tali contraddizioni, contribuendo a creare le premesse per la costruzione di un blocco sociale anticapitalista che non può prescindere dall’apporto del movimento delle donne? Credo si possa rispondere positivamente, grazie al lavoro di una serie di autrici che stanno gettando le basi di un nuovo “femminismo socialista” di cui Nancy Fraser rappresenta, a mio parere, l’esponente più significativa[xii]. Sintetizzerò qui di seguito alcune sue tesi, concentrando l’attenzione sull’articolo di “MicroMega” citato in apertura.
Il nodo centrale attorno al quale si sviluppa la riflessione di Fraser nel testo in questione è l’estensione del concetto di crisi capitalistica, estensione che avviene integrando nell’idea di crisi capitalistica generale il concetto di “crisi della cura”. Si tratta di un’operazione che comporta, da un lato, il superamento delle interpretazioni “economiciste” della società capitalista, dall’altro lo spostamento delle contraddizioni principali del sistema all’esterno del modo di produzione e delle relazioni di mercato (Fraser richiama in particolare l’attenzione sulla contraddizione che si genera al confine fra produzione e riproduzione). Si potrebbe osservare che lo spostamento delle radici della crisi al di fuori della sfera della produzione e del mercato non è una novità. In merito basti citare: 1) la tesi di Polanyi[xiii] sul carattere anomalo del capitalismo, in quanto unica formazione sociale che abbia tentato di fondare l’intero sistema delle relazioni umane sullo scambio mercantile, tesi che interpreta le crisi come effetto, non tanto e non solo delle contraddizioni immanenti al modo di produrre, quanto del conflitto fra capitalismo e mondi della vita (i quali lottano per la sopravvivenza manifestando la propria irriducibile estraneità alle relazioni economiche); 2) la tesi di Rosa Luxemburg[xiv] secondo cui l’accumulazione capitalistica può avvenire solo grazie allo sfruttamento di strati sociali, Paesi, attività e relazioni umane ad essa esterne (tesi che presenta analogie con quelle dei teorici dello scambio ineguale centro-periferia[xv]); 3) la rilettura della categoria gramsciana di egemonia da parte del filosofo argentino Ernesto Laclau[xvi], il quale propone di sostituire il concetto di modo di produzione con quello di “formazione egemonica”, concetto fondato sull’idea che l’antagonismo non sia interno ai rapporti di produzione ma abbia luogo fra i rapporti di produzione e qualcosa di esterno ad essi; 4) infine va ricordato che lo stesso femminismo degli anni Sessanta e Settanta aveva richiamato l’attenzione sulla sfera riproduttiva come presupposto indispensabile all’esistenza del modo di produzione capitalista. Tuttavia l’approccio di Fraser, pur presentando analogie con le tesi appena elencate, ha il merito di proporre una versione originale della coppia oppositiva dentro/fuori.
Come Polanyi, Fraser sostiene che, fin dall’inizio, la società capitalistica ha separato il lavoro di riproduzione sociale dal lavoro di produzione economica. Il primo si svolge al di fuori del mercato – nelle case, nei quartieri, nelle reti informali e nelle istituzioni pubbliche – e solo in minima parte assume la forma del lavoro salariato. Al tempo stesso, come Luxemburg e altri, sostiene che queste attività “non economiche”, rappresentano una precondizione dell’esistenza stessa del sistema economico. Tuttavia, aggiunge, la propensione del capitalismo all’accumulazione illimitata tende a destabilizzare i processi di riproduzione sociale da cui pure dipende, ed è appunto da questa contraddizione antagonistica – che si colloca sul confine che separa e unisce al tempo stesso produzione e riproduzione – che nasce la “crisi della cura”, una crisi che assume modalità e intensità inedite nel contesto dall’attuale capitalismo finanziarizzato. Per afferrare meglio il senso dell’ultima affermazione, occorre seguirla nel suo tentativo di distinguere fra tre differenti fasi storiche del moderno sviluppo capitalistico. Il capitalismo liberale del secolo XIX lascia alle classi lavoratrici il compito di riprodursi autonomamente al di fuori del circuito mercantile. In questa fase le sfere produttiva e riproduttiva si separano e vengono rispettivamente affidate al lavoro salariato maschile e al lavoro gratuito delle donne. Il sistema capitalistico regolato dallo Stato del XX secolo “re-internalizza” la riproduzione sociale attraverso le istituzioni del welfare, il “salario familiare” sostituisce il salario dei capifamiglia, anche se le relazioni di subordinazione femminile restano più o meno immutate. L’attuale capitalismo finanziarizzato e globalizzato arruola in massa le donne nella forza lavoro salariata, promuove lo smantellamento del welfare e ri-esternalizza il lavoro di cura nelle famiglie – ora divenute bi-reddito – e nelle comunità, ma al tempo stesso diminuisce radicalmente la capacità di queste ultime di sostenerlo (a parte le minoranze di coloro che possono permettersi di mercificarlo). “Se il regime precedente alleava la mercatizzazione con la protezione sociale contro l’emancipazione, scrive Fraser, questo genera una configurazione anche più perversa, in cui l’emancipazione si unisce alla mercatizzazione per indebolire la protezione sociale”[xvii].
È proprio cogliendo questa combinazione perversa di emancipazione e mercatizzazione che Fraser offre quello che forse è il suo contributo più importante all’analisi delle contraddizioni del capitalismo contemporaneo. La “perversione” è il frutto della convergenza fra la “guerra di classe dall’alto” – per usare le parole di Luciano Gallino[xviii] – del capitale contro le ridotte capacità di resistenza della forza lavoro dei paesi occidentali e le rivendicazioni dei nuovi movimenti sociali (femministe, ecologisti, LGBTQ, ecc.) i quali, sostiene Fraser riprendendo e approfondendo le tesi di Boltanski e Chiapello[xix] , hanno dato vita a un paradossale “neoliberismo progressista” che celebra la diversità, la meritocrazia e l’emancipazione mentre accetta o addirittura considera come positivo lo smantellamento delle forme di protezione sociale tipiche della precedente fase capitalistica. La critica contro ogni tipo di gerarchia – di sesso, genere, etnia, razza e religione – viene fatta propria da un capitalismo gauchiste che si incarna nelle imprese della Silicon Valley, nell’industria culturale di Hollywood e nelle produzioni immateriali di servizi avanzati, mentre trova espressione politica nei Democratici alla Clinton, nel New Labour di Tony Blair e nelle sinistre socialdemocratiche europee. Al tempo stesso la rabbia delle classi subalterne che, abbandonate dai loro rappresentanti storici, si rivolgono ai populismi di destra, viene liquidata con disprezzo come fascista, razzista e sessista da questa sinistra sex and the city.
Questo equivoco connubio, aggiungerei, esercita tuttora un’influenza negativa anche nei confronti di quell’ala femminista che pure, come sopra ricordato, sta riscoprendo i temi della lotta anticapitalista, nella misura in cui l’immaginario del “femminismo di regime” – come l’ho definito nel mio ultimo libro[xx], contribuisce a dirottare l’attenzione e le energie verso una lotta al “patriarcato” che suona anacronistica nel contesto di una società capitalista il cui immaginario dominante, scrive la Fraser, “è liberale-individualista ed egualitarista rispetto al genere: le donne sono considerate uguali agli uomini in ogni sfera, meritevoli di uguali opportunità per realizzare i loro talenti, compreso – forse in modo particolare – nella sfera della produzione. La riproduzione, per contro, appare come un residuo arretrato, un ostacolo al progresso da eliminare, in un modo o nell’altro, nella strada verso la liberazione”. Liberazione di chi? Dietro l’aura “femminista” dell’attuale società capitalista avanzata si nasconde non tanto la disparità salariale e di opportunità di carriera (prodotto di una strategia di divisione fra lavoratori più che del permanere di pregiudizi di genere), quanto il permanere d’una separazione produzione-riproduzione su basi di genere che non riguarda più le famiglie della middle class e gli strati superiori del proletariato dei Paesi occidentali, bensì le lavoratrici migranti “importate” dalle nazioni povere. “Lungi dal colmare il divario della cura, l’effetto netto è di delocalizzarlo – dalla famiglie più ricche alle più povere, dal Nord globale al Sud globale”. Si potrebbe dire che, da un lato, il capitalismo come forma sociale “pura” – così come è evoluto nei suoi centri storici – non ha di per sé alcuna relazione necessitante con le gerarchie di genere: ha convissuto con il patriarcato finché questo è stato funzionale alla sua autoriproduzione, ma oggi può farne tranquillamente a meno (potrebbe persino convivere con inedite forme di matriarcato, anche se la verità è – vedi sopra quanto affermato da Luisa Muraro – che il suo interesse ultimo sarebbe la neutralizzazione della differenza sessuale e dei suoi effetti destabilizzanti). Dall’altro lato, nella misura in cui non può sopravvivere senza attingere risorse di ogni tipo (naturali, umane, cognitive, ecc.) al proprio esterno, è costretto a tenere in vita il patriarcato esternalizzandolo, esattamente come esternalizza la produzione materiale verso i Paesi in via di sviluppo.
A mo’ di conclusione non mi resta che auspicare che le analisi di Nancy Fraser funzionino da riferimento teorico per le correnti anticapitaliste interne al femminismo, aiutandole a ricavarsi un ruolo egemonico nel movimento delle donne e a contenere l’influenza delle correnti “emancipazioniste” e dell’estremismo “genderista” (che funzionano da vie di penetrazione dell’immaginario neoliberista nel movimento). Aggiungo solo alcune brevi considerazioni sul contributo che un approccio come quello della Fraser può dare al superamento di quella oscillazione fra cattivo universalismo e cattivo relativismo di cui mi sono occupato nella prima parte. Da un lato, tematizzare le contraddizioni alto/basso, centro/periferia, produzione/riproduzione che attraversano i confini di genere implica superare qualsiasi concezione dell’universalità come dato apriori, ascrivibile a questo o a quel soggetto di classe, genere, sesso, razza, etnia, religione ecc. per assumere viceversa l’universale come prodotto di una costruzione politica o, per usare le parole di Laclau, di un “processo di universalizzazione egemonica”. Al tempo stesso, consente di non cadere in una visione “orizzontalista” dei conflitti che metta sullo stesso piano tutte le rivendicazioni di riconoscimento identitario – associate alla progressione insensata e illimitata dei “diritti” di una miriade di sottoculture –, per costruire invece l’unità delle soggettività antagoniste nella contrapposizione contro un nemico comune che altri non può essere se non il sistema di dominio e sfruttamento capitalistico.
(19 gennaio 2018)
NOTE
Cfr. <
[ii] Cfr. Il pene concettuale come costrutto sociale, in <
[iii] J. Butler, L’alleanza dei corpi, nottetempo, Milano 2017.
[iv] Cfr. La sacra differenza. Intervista a Luisa Muraro.
[v] N. Fraser, Contraddizioni del capitale e del ‘lavoro di cura’.
[vi] L’alleanza dei corpi, cit.
[vii] C: Formenti, La variante populista, DeriveApprodi, Roma 2016.
[viii] Fra gli altri, anche Mario Tronti ha preso le distanze dagli inviti a convergere tutti sotto le bandiere dei valori occidentali. Cfr. Dello spirito libero, il Saggiatore, Milano 2015.
[ix] Cfr. intervista citata in nota IV.
[x] Ivi.
[xi] Ivi.
[xii] Cfr. fra le altre, A. Iris, D’Atri, Il pane e le rose. Femminismo e lotta di classe, Red Star Press, Roma 2106; N. Fraser, Fortune of feminism. Verso, London-New York 2014; S. Federici, Il punto zero della rivoluzione. Lavoro domestico, riproduzione e lotta femminista, ombre corte, Verona 2014.
[xiii] Cfr. C. Polanyi, La grande trasformazione, Einaudi, Torino 1974.
[xiv] Cfr. R. Luxemburg, L’accumulazione del capitale, Einaudi, Torino 1960
[xv] Mi riferisco, fra gli altri, ai lavori di Samir Amin, Gunder Frank, Giovanni Arrighi, Emmanuel Wallerstein.
[xvi] Laclau sviluppa il concetto della società capitalistica come formazione egemonica soprattutto nel suo ultimo libro: Le fondamenta retoriche della società, Mimesi, Milano 2017.
[xvii] Contraddizioni del capitale…op. cit.
[xviii] Cfr. L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, Laterza, Roma-Bari 2012.
[xix] Cfr. L. Boltanski – E. Chiapello, Il nuovo spirito del capitalismo, Mimesis, Milano 2014.
[xx] Cfr. La variante…op. cit.
Link articolo: Contro il femminismo di regime