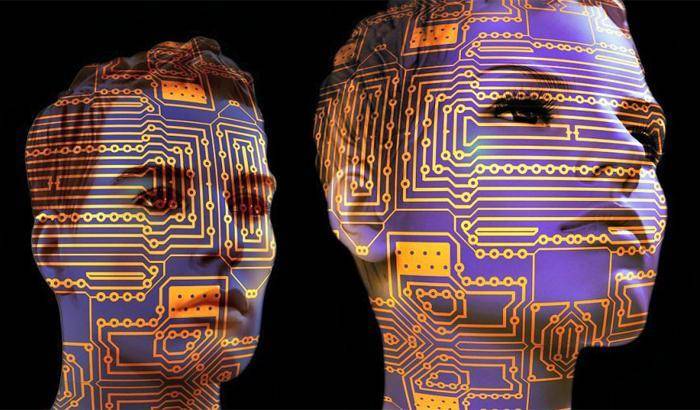di Andrea Daniele Signorelli*
Questo articolo è stato pubblicato su il Tascabile il 18 gennaio scorso. Ringraziamo l’autore e la redazione de il Tascabile per averci concesso di riprenderlo qui. (pfdi)
***
In 15 anni, il numero di ragazzi in età scolastica che nel Regno Unito fa uso di Ritalin – uno stimolante nato per aiutare gli studenti affetti dal Disturbo da Deficit di Attenzione (ADHD) – è salito dai 92.000 del 1997 ai 786.000 del 2012. Negli Stati Uniti, già nel 2011, questo numero superava i 3,5 milioni e – stando a quanto riporta la rivista specializzata Neuropharmacology (nel numero 64 del 2013) – una percentuale tra il 5 e il 15% degli studenti di college utilizza il Ritalin per migliorare le proprie performance.
Un incremento che non è ovviamente causato da un’epidemia di deficit di attenzione, ma dalla trasformazione degli obiettivi per cui si utilizza questo farmaco: “Lo scopo originario era quello di trattare il disordine dell’attenzione”, scrive Yuval Noah Harari in Homo Deus. “Ma oggi ragazzi completamente in salute prendono questi farmaci per stare al passo con le crescenti aspettative di genitori e insegnanti”. La ragione principale dell’utilizzo del Ritalin sembra diventata quella di soddisfare le richieste della società e aiutare gli studenti a essere più preparati e quindi in grado di affrontare con successo un mercato del lavoro segnato da una competizione estrema.
Non è certo un caso isolato: osservando da vicino gli sviluppi tecnologici (e anche biotecnologici e neurofarmacologici) non è difficile notare come tutte le innovazioni (del passato recente, del futuro prossimo o in fase di sviluppo) sembrino avere un unico obiettivo: rendere l’essere umano più rapido e più produttivo. In una parola: più efficiente. Il simbolo stesso di tutto ciò, ovviamente, è lo smartphone: secondo una ricerca del Center for Creative Leadership, chi utilizza lo smartphone anche come strumento professionale rimane in qualche modo connesso al suo lavoro per 13,5 ore al giorno. Più o meno tutto il tempo in cui si è svegli esclusi i pasti. Un eccesso di lavoro causato dal fiume di notifiche (mail, Messenger, WhatsApp, sistemi di gestione come Trello o Slack) che ci inonda da appena svegli e ancora a letto fino a sera inoltrata; tracimando anche nei weekend.
Tutto ciò, al di là dei risvolti sociali variamente analizzati, ci rende più produttivi (o almeno ci dà la sensazione di esserlo) incrementando le ore dedicate al lavoro. Quando l’iPhone ha fatto la sua comparsa nel 2007, tra i vari slogan elaborati da Steve Jobs e colleghi c’erano: “Questo cambia tutto”, “Apple reinventa il telefono”, “È solo l’inizio”. Nessuno slogan diceva “adesso potrete lavorare molto di più”, eppure è proprio la nostra vita lavorativa a essere stata enormemente colpita dall’avvento degli smartphone.
Non si è trattato di un unicum, ma di una tendenza che con l’avvento delle nuove tecnologie si consoliderà ulteriormente e che raggiungerà il suo picco quando (e se) si concretizzeranno le sperimentazioni in corso nel campo della stimolazione elettrica del cervello e dell’editing genetico. Prima di arrivare alla frontiere più futuribili soffermiamoci sulle conseguenze che potrebbe avere un’innovazione molto più vicina: la realtà aumentata; la tecnologia che sovrappone il digitale al reale, cancellando definitivamente la distinzione tra i due ambiti e permettendoci di vivere, sfruttando dei visori, in un mondo costantemente aumentato.
L’efficienza della realtà aumentata
Il prototipo da poco presentato dalla più celebrata startup del settore, Magic Leap, ha sollevato non poche ironie: un paio di occhiali estremamente ingombranti, che ci costringono a circolare con un minicomputer attaccato alla cintola e a tenere sempre in mano una sorta di telecomando. Se qualcuno oggi andasse in giro conciato in questa maniera, si coprirebbe di ridicolo, ma questo è solo l’inizio: col passare del tempo, i visori diventeranno sempre più simili a normali occhiali; il minicomputer entrerà in una mano e il telecomando potrebbe anche completamente sparire, permettendoci di dare i comandi solo per via vocale o con i gesti.
La maggior parte degli analisti ritiene che sia questa la next big thing destinata a rimpiazzare lo smartphone. Sensazione confermata dal fatto che tutti i colossi del settore (da Apple, a Facebook, compresi Google e Microsoft) stiano investendo massicciamente nel campo. Kevin Kelly, nel suo ultimo libro L’inevitabile (Il Saggiatore), immagina una giornata in un futuro aumentato. Eccone uno scorcio:
Inforco gli occhiali per la realtà aumentata mentre corro all’aperto. Il percorso è dritto davanti a me e posso vedere in sovraimpressione tutte le misurazioni del mio allenamento, come per esempio il battito cardiaco e lo stato del mio metabolismo in tempo reale. Posso anche visualizzare le ultime annotazioni virtuali sui posti in cui passo. Sui miei occhiali vedo una nota su un tragitto alternativo che un mio amico ha fatto quando ha percorso questa stessa strada un’ora prima e vedo anche delle annotazioni storiche associate a un paio di punti di riferimento che sono state lasciate dal club di storia locale di cui sono membro. Un giorno potrei anche provare l’applicazione per il riconoscimento degli uccelli, che associa un nome a quelli che vedo mentre corro nel parco.
L’aspetto probabilmente più importante dei visori per la realtà aumentata è che rendono l’unione tra reale e digitale frictionless, priva cioè di quella frizione tra i due ambienti che contraddistingue le applicazioni AR degli smartphone. Con Magic Leap e gli altri, i due piani si fonderanno definitivamente. Anche in questo caso, si tende a evidenziare soprattutto le potenzialità della AR nel campo dei videogiochi, dello shopping (Ikea sta lavorando a un programma che permetterà, usando i visori, di vedere come stanno i mobili in casa nostra), del turismo (le informazioni appariranno direttamente sui monumenti), della navigazione stradale (le indicazioni saranno direttamente inglobate nelle strade che percorriamo). Molto meno si parla invece di quanto i visori in realtà aumentata ci obbligheranno a essere ancora più produttivi ed efficienti.
Le mail, le telefonate, le notifiche, gli appuntamenti non saranno più nel nostro smartphone, ma appariranno direttamente davanti ai nostri occhi; aumentando ancor più la nostra capacità di gestirle in tempo reale, qualunque attività si stia svolgendo. E se adesso dobbiamo decidere di prendere in mano lo smartphone per collegarci, nel futuro (che dista solo un paio d’anni) dovremo decidere di toglierci il visore per scollegarci. Una differenza fondamentale: la nostra condizione di base sarà connessa alla rete e al fiume di attività lavorative e non che possiamo gestire con gli headset; per staccare dovremo decidere di levarceli dagli occhi.
Questo ribaltamento è però solo un passaggio intermedio. Parecchie aziende – in vantaggio sembra essere Samsung – stanno già brevettando le lenti a contatto smart. Una prospettiva che dista ancora parecchio, ma che integrerà definitivamente il digitale nel corpo umano. A quel punto, forse, ci sconnetteremo solo per andare a dormire; il resto del nostro tempo sarà invece sempre immerso nella rete. Le ricadute lavorative sono evidenti: la nostra costante e immediata reperibilità verrà data ancor più per scontata; così come la capacità di monitorare non-stop tutto ciò che compare sui monitor che, a quel punto, si troveranno letteralmente appoggiati ai nostri occhi.
Un problema di tempo
Tutto può aumentare: produttività, lavoro, consumo. Ciò che non può aumentare è la durata della giornata: nell’epoca dell’abbondanza (delle società avanzate) il bene scarso è diventato il tempo. Una ricerca della Harvard Business School, condotta su mille professionisti, mostra come il 94% di loro lavori almeno 50 ore a settimana; e quasi la metà ne lavori oltre 65. Altre ricerche mostrano come la quota di uomini statunitensi laureati che lavorano oltre 50 ore a settimana sia cresciuta dal 24% del 1979 al 28% del 2006 (facile immaginare che nel frattempo sia ulteriormente aumentata).
E meno male che, negli anni Trenta, John Maynard Keynes immaginava che verso la fine del millennio scorso si sarebbe lavorato per tre ore al giorno. La verità è che, nonostante il tempo libero sia complessivamente cresciuto negli ultimi decenni, la maggior parte dell’incremento si è ottenuto tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta; dopodiché gli economisti hanno notato come si sia venuto a creare un gap crescente, in cui la maggior parte del tempo libero viene goduto da persone che hanno un basso grado d’istruzione. Negli Stati Uniti, chi non ha terminato le scuole superiori ha incrementato il proprio tempo libero di otto ore a settimana dal 1985 al 2005. Gli uomini laureati, nello stesso lasso di tempo, hanno invece visto diminuire il tempo libero di sei ore (la sola ragione per cui si continua a parlare di uomini è che la situazione delle donne, ovviamente, è molto diversa, ancor più penalizzata e meriterebbe un trattamento a parte).
Avere “troppe cose da fare” è diventato un simbolo di status. Ma c’è un problema: i lavori attualmente considerati di livello medio-basso saranno a breve svolti dalle macchine e dalle intelligenze artificiali; lasciando a nostra disposizione solo le professioni che richiedono abilità in cui l’uomo è (per il momento) migliore; lavori non ripetitivi, che necessitano di capacità particolari: creatività, gestione e supervisione di un gruppo, rapporti umani e quant’altro.
La diminuzione del numero di lavori non significa solo che la concorrenza sarà sempre più spietata – costringendo ognuno di noi a raggiungere nuovi livelli di istruzione, produttività ed efficienza – ma soprattutto che, per tenere testa all’avanzata delle AI, dovremo continuamente migliorare e diventare sempre più rapidi. Come ha recentemente affermato Elon Musk, gli uomini dovranno “aumentare se stessi” al solo scopo di tenere il passo delle macchine. Per riuscire nell’impresa, non basterà certo un visore in AR in grado di accrescere la nostra produttività ed efficienza.
Nuove abilità
Negli ultimi anni ha preso piede una quantità di progetti estremamente ambiziosi – tutti nel campo delle neuroscienze – che hanno un unico obiettivo: aumentare le abilità umane. Proprio Elon Musk è l’ideatore di uno di questi: Neuralink, la società dedita alla creazione di un’interfaccia uomo-macchina che, attraverso un “laccio neurale”, punta ad aumentare le capacità del cervello umano. Le prime possibili applicazioni sono mediche: persone affette da malattie neurologiche come il Parkinson o l’Alzheimer potrebbero beneficiare enormemente dallo sviluppo di una tecnologia di questo tipo, come già avviene grazie a tecniche sperimentali che prevedono l’innesto di elettrodi wireless nel cervello.
È un campo in cui sono stati ottenuti notevoli successi. Un esempio tutto italiano è quello di Brain Control; il CEO Pasquale Fedele, in occasione dell’ultimo Wired Next Fest di Milano, ha spiegato: “Attraverso un caschetto, intercettiamo e leggiamo l’attività elettrica che i neuroni generano interagendo tra di loro. In questo modo, quando un paziente completamente paralizzato pensa di muovere la carrozzina in avanti, o di rispondere positivamente o negativamente a una domanda usando come tramite un tablet, il nostro software individua l’attività neuronale in tempo reale e produce l’azione pensata”.
Una startup come Kernel – registrata come società che opera in campo medico – conduce invece le sue sperimentazioni inserendo chip all’interno del cervello, allo scopo di individuare le cause degli attacchi epilettici o per combattere anoressia e obesità. Ma per il futuro la speranza è di usare la stessa tecnologia per aumentare la memoria, imparare più rapidamente e magari sbloccare il segreto della telepatia. Le sperimentazioni mediche in questo settore si stanno insomma moltiplicando; ma rappresentano solo la testa d’ariete, la giustificazione più nobile per proseguire nello sviluppo di dispositivi che, in futuro, potrebbero rendere tutti noi in grado di controllare le macchine, ricevere informazioni dai computer e comunicare l’un l’altro usando solo il cervello (fino ad arrivare all’utopia della “intelligenza collettiva”).
Altri progetti più realistici sembrano comunque perseguire gli stessi obiettivi: il team dell’Università di Oxford guidato da Roi Cohen Kadosh sta studiando come la stimolazione elettrica del cervello eseguita attraverso la TRNS (Transcranial Tandom Noise Stimulation) potrebbe permetterci di imparare la matematica con una rapidità molto maggiore. Le persone sottoposte a questi stimoli elettrici durante le sessioni di prova hanno appreso con una velocità superiore da due a cinque volte, conservando dal 30 al 40% della loro performance anche a distanza di sei mesi.
Umanità geneticamente modificata
Perché fermarsi qui? Passando dagli impianti tecnologici allo studio dei geni e ai modelli predittivi basati sul DNA, startup come Genomic Prediction, 23andMe e altre potrebbero essere in grado di identificare i geni responsabili della nostra intelligenza e quindi riconoscere gli embrioni umani destinati ad avere un QI più o meno elevato. Anche in questo caso, le applicazioni eticamente accettate sono solo quelle mediche: “Riveleremo solo le possibili condizioni gravemente negative; non diremo mai vostro figlio diventerà un giocatore della NBA o un genio della fisica”, ha spiegato il fondatore di Genomic Prediction Stephen Hsu alla MIT Tech Review. Ma non sarà facile controllare gli sviluppi: già nel 2013, 23andMe aveva provocato scandalodepositando un brevetto che, consentendo ai genitori di selezionare i donatori di gamete attraverso calcoli genetici, sembrava essere il primo passo verso l’eugenetica (salvo poi fare retromarcia).
Stephen Hsu di Genomic Prediction – che ha più volte confermato come la sua società sia intenzionata esclusivamente a evitare che nascano bambini con gravi malattie (il che solleva comunque parecchi problemi etici) – è però anche l’autore di un saggiopubblicato su Nautilus con il titolo “Gli umani super-intelligenti stanno arrivando”, in cui spiega come, attraverso l’editing genetico e tecniche come Crispr, potrebbe diventare possibile, nel giro di pochi anni, aumentare il QI dei propri figli di 15 punti senza troppe difficoltà (“la differenza tra un bambino che avrà difficoltà a scuola e uno che completerà con successo il college”); con la prospettiva di arrivare, un giorno, fino a 1000.
Nel suo saggio, Hsu richiama il racconto Fiori per Algernon di Daniel Keyes, in cui un adulto di nome Charlie Gordon riceve un trattamento sperimentale che gli consente di aumentare il suo QI da 60 (molto basso) fino a circa 200, trasformandosi da un panettiere di cui gli amici si approfittano in un genio capace di vedere tutte le connessioni del mondo senza alcuno sforzo: “Vivo al picco di una chiarezza e di una bellezza che non sapevo nemmeno esistessero”, scrive Charlie. “Non c’è gioia più grande dell’esplosione della soluzione a un problema. Questa è bellezza, amore e verità tutto in uno. Questa è gioia”.
Fuori dalla narrativa, secondo Hsu l’editing genetico con lo scopo di aumentare il nostro QI potrebbe dotarci di una memoria visiva quasi perfetta, di un pensiero super veloce, di una visualizzazione geometrica estremamente potente, della capacità di formulare più pensieri contemporaneamente. Ma perché dovremmo volere tutto questo? Secondo Bryan Johnson, fondatore della già citata Kernel, la ragione è semplice: “Il mondo è diventato fin troppo complesso; il sistema finanziario è imprevedibile, la popolazione invecchia, i robot vogliono il nostro lavoro, l’intelligenza artificiale ci sta raggiungendo e il cambiamento climatico non sembra prossimo ad arrestarsi. Tutto sembra fuori controllo. E allora, perché non dovremmo decidere noi stessi in quale direzione evolvere? Perché non dovremmo fare tutto il possibile per adattarci più rapidamente?”.
Quindi: un capitalismo sempre più veloce ci costringerà ad adottare nel breve termine dispositivi tecnologici che sembrano avere lo scopo di farci produrre e consumare di più (fornendo allo stesso tempo anche più dati); la rincorsa delle macchine ci obbliga a studiare sul medio termine delle tecniche in grado di aumentare drasticamente le nostre capacità intellettuali e la crescente complessità del mondo ci obbliga a evolvere artificialmente. Dove ci porterà tutto questo?
I primissimi segnali della direzione che stiamo intraprendendo si possono già oggi trovare nella diffusione della on-demand economy, resa possibile dalla tecnologia e che dovrebbe impiegare 10 milioni di statunitensi entro il 2021. Un sistema iper-liberista che ci costringe a diventare il “capitalista di noi stessi”, premiando esclusivamente chi è in grado di partecipare con successo a un mercato del lavoro sempre più competitivo e che richiede un grado sempre maggiore di preparazione e dedizione (abbandonando a se stessi tutti gli altri).
In una società di questo tipo, i primi esseri umani che riusciranno ad aumentare artificialmente la propria efficienza godranno di un enorme vantaggio su tutti gli altri; mentre i primi che potranno selezionare gli embrioni offriranno un vantaggio strategico ai loro figli. E chi si potrà permettere tutto ciò?: “I primi ad adottare le tecnologie di selezione dell’embrione saranno i miliardari e i tipi da Silicon Valley”, si legge ancora sulla MIT Tech Review. “Nel momento in cui loro inizieranno a produrre meno bambini malati, e più bambini eccezionali, il resto della società non potrà che seguire”. Fa eco a queste parole anche lo stesso Stephen Hsu: “Come avviene con la maggior parte delle tecnologie, i ricchi e potenti saranno i primi a beneficiarne”.
Questo, ovviamente, non varrà solo per l’editing genetico (le cui prospettive sono ancora tutte da vedere), ma anche per la possibilità di sfruttare i concreti sviluppi della stimolazione cerebrale, di progetti come Neuralink e altri ancora. E così, i “ricchi e potenti” avranno nelle loro mani un ulteriore strumento, ancor più potente di quelli che già oggi possiedono (in termini di migliore istruzione e corsie preferenziali per l’accesso al mondo del lavoro), per sfruttare (e tramandare) i loro privilegi e accrescere ulteriormente la già crescente disuguaglianza.
Uomini come risorse naturali
Così come si scava sempre più a fondo per trovare petrolio o si usa la tecnologia per far fruttare di più il suolo, allo stesso modo l’uomo è costretto ad aumentare se stesso per essere sempre più produttivo e in grado di soddisfare la sete di crescita del nostro sistema economico. In tutto ciò, le innovazioni tecnologiche e biomediche giocano un ruolo chiave, rendendoci più integrati con il digitale e quindi più efficienti – un domani ci potrebbero rendere selezionati con più cura e quindi in grado di essere sempre più razionali, più intelligenti, in grado di prendere più decisioni, più corrette e in tempi più rapidi.
“I computer sono dispositivi molto ben progettati”, scrive Hugh Howey su Backchannel. “Tutti i vari bit sono stati progettati nello stesso momento e con gli stessi obiettivi, e sono stati progettati per lavorare armoniosamente l’uno con l’altro. Niente di tutto ciò, in nessun modo, ricorda la mente umana. La mente umana è molto più simile a Washington (o qualunque altro imponente governo). Alcune funzioni del cervello sono state costruite centinaia di milioni di anni fa, come quello che forniscono energia alle cellule. Altre sono state costruite milioni di anni fa, come quelle che sparano i neuroni e si assicurano che il sangue venga pompato e l’ossigeno inalato. Andando verso il lobo frontale, troviamo i moduli che controllano i comportamenti da mammiferi”.
I diversi bisogni delle differenti ere a cui, lentamente, si adatta l’evoluzione umana fanno sì che l’uomo risponda ancora oggi a necessità ancestrali che la nostra società ha abbandonato da tempo e che non sia affatto un fulgido esempio di razionalità ed efficienza. Perché mai, allora, tutti questi timori sul rischio che gli scienziati creino AI uguali all’uomo? E infatti, prosegue Howey, “non dovrebbe essere quello l’obiettivo. L’obiettivo dovrebbe essere di andare in direzione opposta. Dopo milioni di anni di competizione per le risorse, l’algoritmo del cervello umano causa oggi più problemi di quelli che risolve”.
In parole povere, non dobbiamo temere che le intelligenze artificiali diventino come gli uomini, perché la direzione che abbiamo intrapreso è quella opposta: siamo noi che stiamo diventando sempre più efficienti, razionali e produttivi a scapito della nostra umanità e (probabilmente) del nostro benessere. Allo scopo di assicurarci che la nostra società continui a inseguire il mito della crescita, siamo noi che stiamo diventando sempre più simili alle intelligenze artificiali.
(18 gennaio 2018)
*Andrea Daniele Signorelli milanese, classe 1982, si occupa del rapporto tra nuove tecnologie, politica e società. Scrive per La Stampa, Wired, Il Tascabile, Pagina99 e altri. Nel 2017 ha pubblicato Rivoluzione Artificiale: l’uomo nell’epoca delle macchine intelligenti per Informant Edizioni.
Link articolo: Superumani